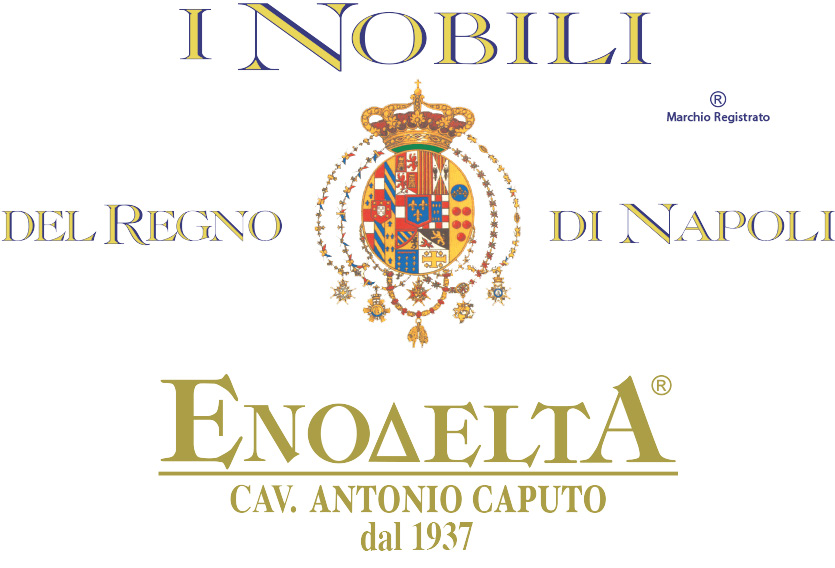Rubrica a cura di Enrico Fagnano: Il Mezzogiorno dopo l’Unità
CLICCA QUI PER LA PRIMA PARTE
Due provvedimenti, che lasciarono senza reddito un grande numero di Meridionali, furono lo scioglimento del Corpo dei Volontari, ovvero dell’esercito garibaldino, e lo scioglimento dell’esercito delle Due Sicilie. Quando Garibaldi arrivò a Napoli, al suo seguito c’erano quasi 40.000 uomini, provenienti in parte dal Nord, ma in parte anche dal Sud, ai quali successivamente se ne aggiunsero altri 10.000 circa, ma questi ultimi in realtà non avevano combattuto e si aggregarono agli assalitori per procurarsi benefici o, più semplicemente, per procurarsi un reddito. Molti si aspettavano, infatti, che a quel punto le camice rosse, vere artefici della conquista, sarebbero state arruolate tra le truppe regolari. Gli uomini del governo, però, non vedevano di buon occhio l’inserimento nelle forze armate dei volontari, non solo per l’indisciplina, come dichiarava il generale Manfredo Fanti, ministro della guerra e capo dello stato maggiore, ma anche perché si riteneva che fossero repubblicani e mazziniani, almeno quelli veri, e quindi la loro presenza avrebbe costituito un pericolo per la monarchia sabauda.
Dopo la partenza di Garibaldi per Caprera, avvenuta come sappiamo il 9 novembre 1860, con decreto regio dell’11 novembre venne, quindi, deliberata la liquidazione dei suoi militari con una somma equivalente a sei mesi di paga (la relativa spesa, inutile dire, fu a carico delle casse dello Stato napoletano) e con la generica prospettiva di costituire in futuro un’armata che li ricomprendesse. Il generale, però, non intendeva abbandonarli e insistette perché fossero arruolati nell’esercito della nuova Italia. Della questione si discusse in Parlamento tra il 18 e il 20 aprile 1861 e il 19 tra Garibaldi (eletto deputato nel primo collegio di Napoli) e Cavour ci fu uno scontro violentissimo, che lasciò il primo ministro fortemente scosso e del quale pochi giorni prima della morte risentiva ancora, come confessò in uno dei loro consueti incontri a Ruggiero Gabaleone, conte di Salmour, suo stretto collaboratore e intimo amico.
Poco prima era stata istituita una commissione, che aveva il compito di individuare i volontari che avevano veramente combattuto con l’obbiettivo, almeno dichiarato, di inserirli nelle truppe nazionali, ma il lavoro, realmente gravoso, procedeva a rilento (sempre ammesso che ci fosse l’intenzione di portarlo a termine), fino a quando il governo presieduto da Urbano Rattazzi con decreto del 27 marzo 1862 non sciolse in maniera definitiva il Corpo delle camice rosse. Solo un ristretto numero di suoi ufficiali vennero accolti nei quadri regolari, mentre venne riconosciuta una pensione minima solo ai componenti del nucleo originario, cioè quelli partiti da Quarto, che dopo essere stati censiti con la collaborazione di Nino Bixio, risultarono 1.084. Tutti gli altri, che erano decine di migliaia, furono lasciati senza nessuna forma di sussistenza (come abbiamo visto, però, già dal novembre 1860 non percepivano alcun compenso) e andarono a ingrossare le fila dei disoccupati, o forse sarebbe meglio dire, dei disperati. Rimasti senza una prospettiva concreta, molti di loro, naturalmente tra quelli meridionali, finirono con l’aggregarsi alla rivolta armata, il cosiddetto brigantaggio, che stava montando nelle campagne e da quel momento si trovarono, paradossalmente, a combattere il nuovo esercito italiano a fianco di militari borbonici, contro i quali si erano scontrati fino a poco tempo prima. I briganti provenienti dalle fila dei garibaldini furono numerosi, calcolabili in diverse migliaia, e tra loro ci fu anche Carmine Crocco, che divenne uno dei capi più famosi degli insorti e trasformò la Basilicata in una vera e propria roccaforte della ribellione.
Ventinovesima puntata. I libri di Enrico Fagnano IL SUD DOPO L’UNITÀ e IL PIEMONTESISMO E LA BUROCRAZIA IN ITALIA DOPO L’UNITÀ sono disponibili sul sito Bottega2Sicilie
Nello stesso periodo di tempo veniva sciolto anche l’esercito delle Due Sicilie, che era composto da 100.000 uomini, e a questa decisione si giunse sostanzialmente per le pressioni da parte dell’Austria. L’impero asburgico, infatti, conosceva le mire del Piemonte sul Veneto e per questo non vedeva di buon occhio il rafforzamento delle sue milizie che, incorporando in blocco quelle meridionali, si sarebbero praticamente raddoppiate. Non dimentichiamo che Vienna aveva già da tempo concentrato truppe in Lombardia ed era reale il pericolo di un suo intervento, nonostante il veto a agire nella penisola posto dall’Inghilterra agli altri Stati. Le forze armate italiane, però, avevano bisogno di nuovi elementi e allora si cercò, comunque, di reclutare almeno una parte dei vecchi soldati delle Due Sicilie. I circa 50.000 che non erano stati coinvolti nelle battaglie, vennero congedati, ma senza prevedere neanche una forma minima di retribuzione e addirittura senza riconoscere la pensione a quelli tra loro che l’avevano maturata. (Bisogna dire, comunque, che Cavour contava di recuperarne una buona quota con la nuova leva, che sarebbe stata indetta con il regio decreto del 20 dicembre 1860. Le cose, però, non andarono come aveva previsto il conte, che non poteva immaginare quanto fosse profondo l’attaccamento alla propria bandiera dei combattenti napoletani e, più in generale, quanto fosse radicata nel Sud l’ostilità per la coscrizione obbligatoria.) Gli altri 50.000, rimasti prigionieri dopo i vari scontri, invece furono spediti al Nord in campi, nei quali dovevano essere addestrati ed allo stesso tempo, secondo i progetti del governo, dovevano essere convinti a prendere servizio nell’esercito unitario. I campi di rieducazione, come eufemisticamente vennero chiamati, in realtà erano veri e propri luoghi di detenzione, nei quali l’esistenza era durissima, in molti casi addirittura al limite della sopravvivenza. Nonostante questo, però, solo pochissimi, non più di 5 o 6 su 100, cedettero, mentre la maggior parte dei soldati borbonici non vollero venire meno al giuramento fatto al loro vero re, Francesco II, e non accettarono di essere arruolati, preferendo subire le conseguenze di quella reclusione ingiustificata.
Tornando ai militari congedati, anche questi andarono ad ingrossare le fila dei disoccupati. Infatti nel Regno delle Due Sicilie, dove la leva sostanzialmente era volontaria, l’esercito era composto da uomini che svolgevano quell’attività per professione e quindi difficilmente avrebbero potuto praticare altri mestieri. La leva obbligatoria in Sicilia, per antica tradizione, non era proprio prevista, ma di fatto, per i tanti motivi di esenzione riconosciuti, non esisteva neanche nei territori continentali del regno. Erano esentati, infatti, i figli unici, gli orfani, i figli di vedovi, i giovani sposati, i giovani religiosi o avviati all’attività religiosa e infine i giovani, il cui reddito risultava necessario per il sostegno del nucleo familiare (e questo caso, vista la situazione dell’epoca, in pratica comprendeva tutti i ragazzi impegnati in un qualsiasi lavoro). In conclusione di fatto restavano assoggettati al servizio militare solo i figli dei benestanti, i quali anche, però, potevano evitarlo, versando allo Stato la cifra di 250 ducati.
Ventinovesima puntata. I libri di Enrico Fagnano IL SUD DOPO L’UNITÀ e IL PIEMONTESISMO E LA BUROCRAZIA IN ITALIA DOPO L’UNITÀ sono disponibili sul sito Bottega2Sicilie